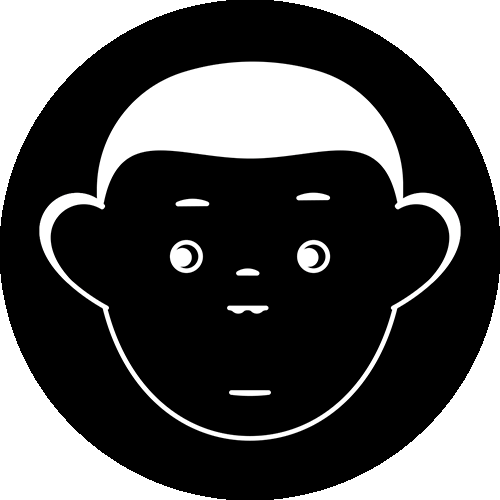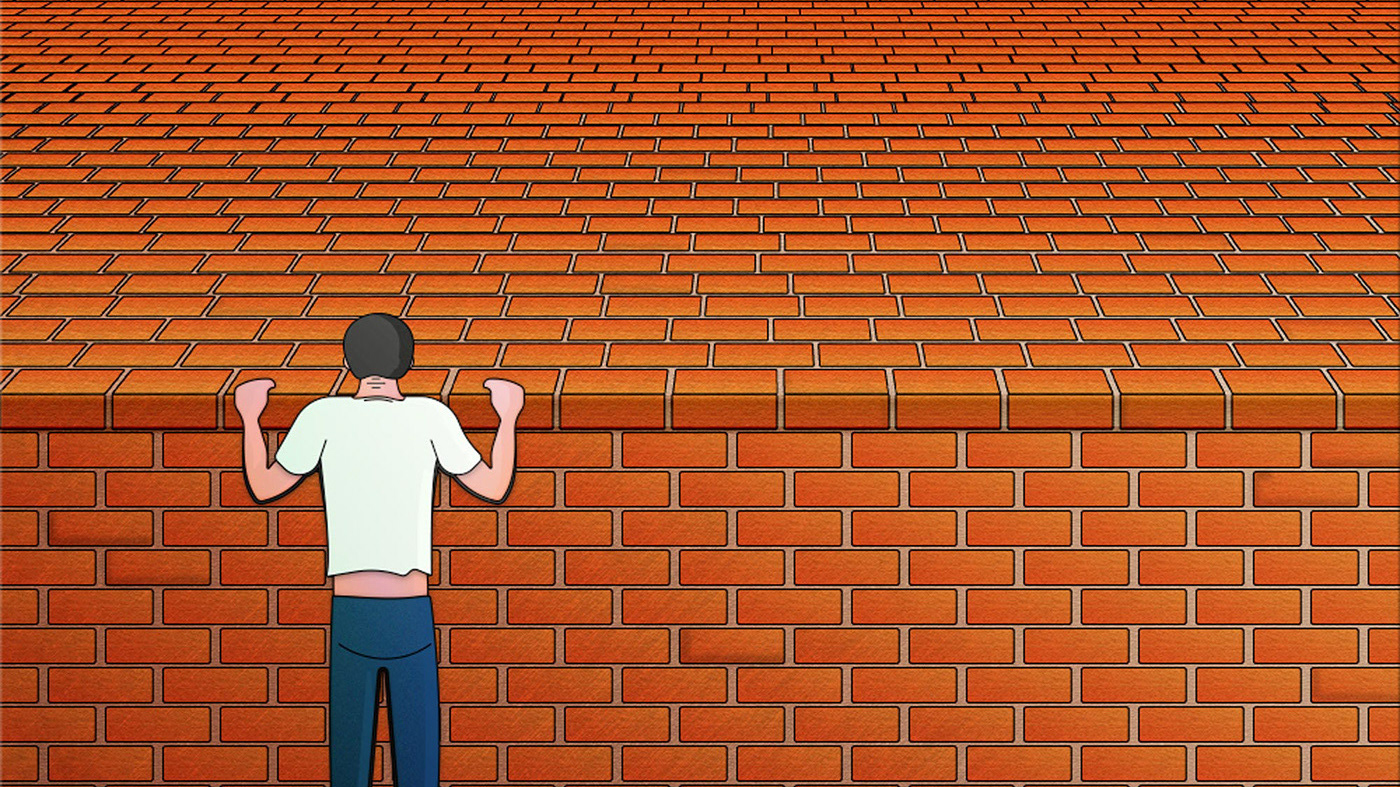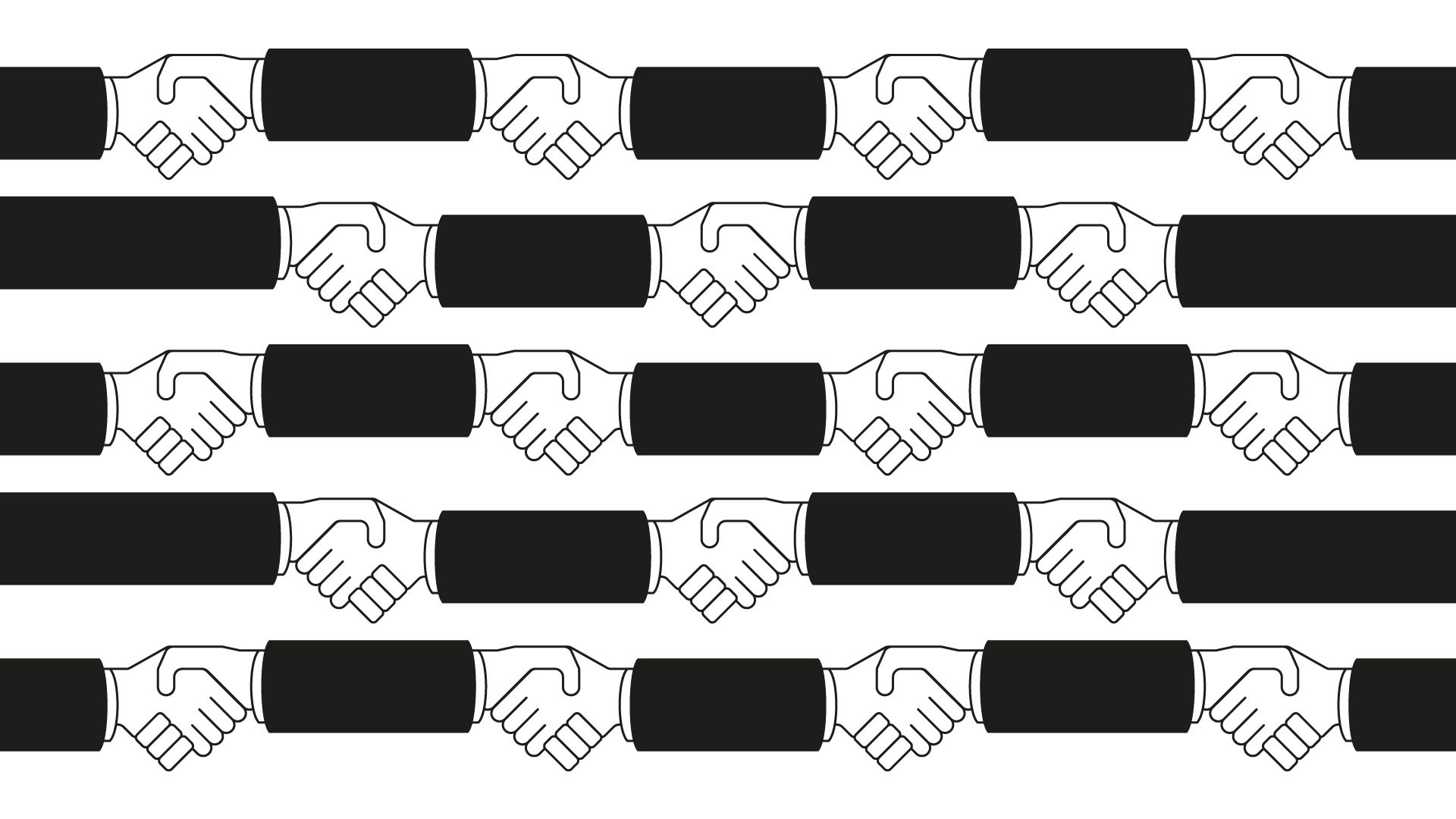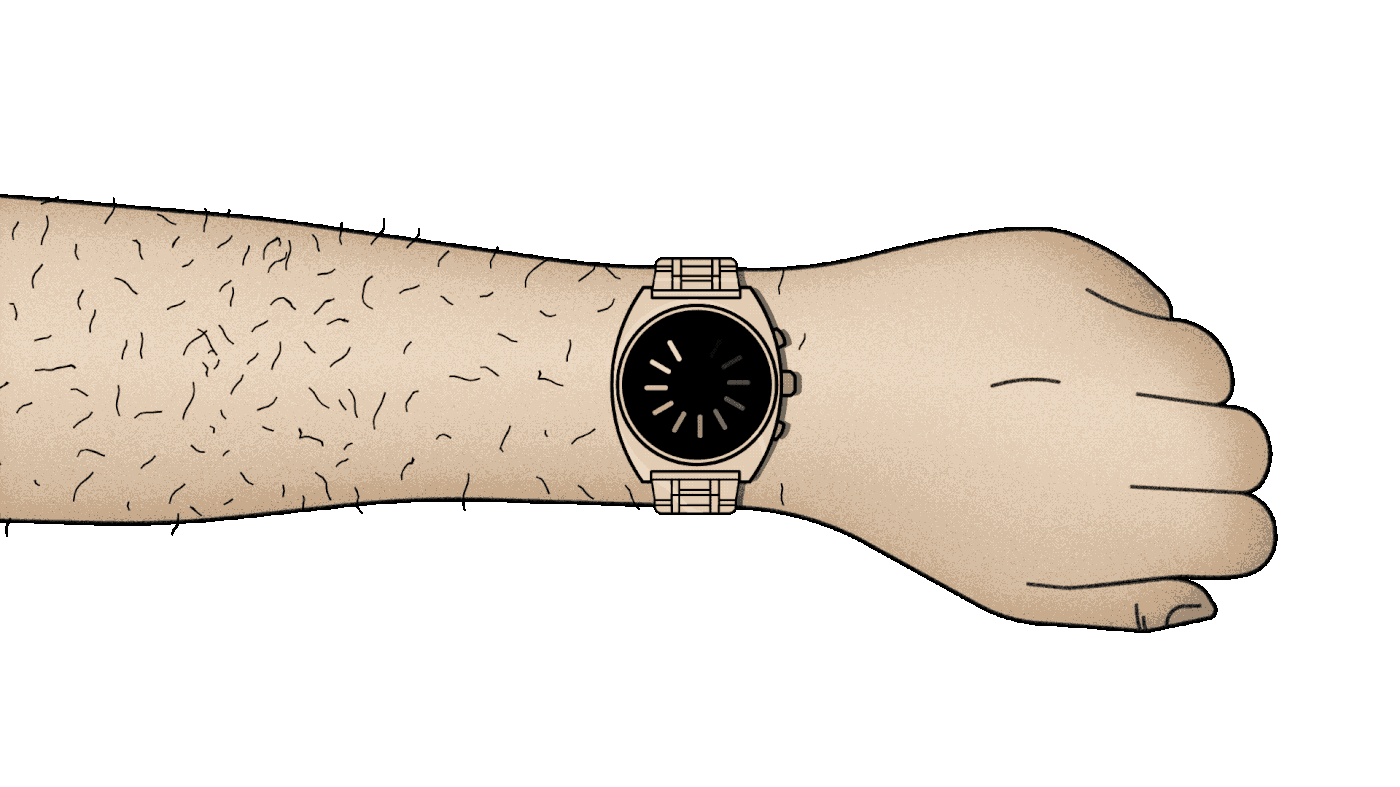Via Giro del Cassero 17
il LATO DEL CERCHIO - MARTEDÍ 10 SETTEMBRE 2019
Le sale d’attesa sono concepite per ampliare al massimo l’esperienza: si deve aspettare. Ogni espediente che cerchi di ingannare l’attesa diventa noioso, tutto è irrilevante rispetto alla chiamata. Alcuni veterani hanno imparato a godersi il momento di stallo; dei ragazzi guardano un video di Sfera Ebbasta; una bambina di cinque anni aspetta assieme alla madre il turno per il prelievo. Ha gli occhi azzurri; richiamano tutta la luce asettica dei neon, colorandola. Sta disegnando su dei post-it ignorando l’atmosfera tediosa prevista in quella stanza. L’anziano che le siede a fianco inizia a scarabocchiare sul foglio dell’impegnativa conversando a disegni con la bambina. Giocano, senza che nessuno li veda.
La bambina, la donna, il vecchio, la trap, le siringhe.
Al tempo delle siringhe non sapevamo chi era Trap. Ne scovavamo le tracce nel cortile, nascoste tra l’erba alta dove le scalinate coprono le aiuole. Se ne trovavamo qualcuna dovevamo chiamare subito i grandi e stare attenti a non toccarle. Sapevamo di doverle evitare come i mozziconi di sigarette o i funghi, ma associavamo il pericolo al dolore dell’ago, niente di più di uno spino, quindi spesso provavamo a stuzzicarle con un ramoscello o a prenderle dalla plastica. Non ricordo cosa pensavo a riguardo, ma avevo la sensazione che qualcuno le avesse messe lì, la loro presenza era premeditata: trappole per bambini. Forse è questa la trap. Crescendo iniziammo ad associare le siringhe alla presenza di Trap, il vicino di casa, poiché i ritrovamenti aumentavano durante le vacanze, quando tornava dalla comunità di recupero.
Andava e veniva da San Patrignano e le sue sporadiche comparse suscitavano in noi un grande interesse. Era il personaggio più misterioso del quartiere sia perché non c’era mai, pur abitando a fianco a noi, sia perché era l’unico con un soprannome (del quale ignoravamo e ignoro tuttora l’origine), ed anche perché, nel nostro immaginario, era “cattivo”: usciva la notte a piazzare le sue siringhe nel prato con lo scopo di infilzarci. La ragione non era chiara, ma spesso i nemici fanno cose malvagie semplicemente perché il loro ruolo lo richiede. Pur temendolo, in qualche modo eravamo riconoscenti alla nostra nemesi: avere un nemico universalmente malvagio permetteva a tutti di essere eroi senza dover assegnarci a turno il ruolo dell’antagonista nei nostri giochi.
Non ho in mente il suo aspetto quando ancora si bucava. La sua immagine si materializza nei miei ricordi già da adulto, ormai disintossicato e stabilmente residente nella porta a metà vicolo. L’ho sempre associato ad un personaggio secondario della “Carica dei 101”: Percival Poswater (il carcerato soggetto delle domande del quiz), per via del naso, dei radi capelli un po’ lunghi, e delle manette, credo. Anche se non ebbe mai guai con la legge la sua latitanza in centri restrittivi lo connotavano come fuorilegge. Viveva con il padre: ricordo le urla, richiami che oltrepassavano tutti i piani fino in camera mia, confinante con quella di Ruggero: suo babbo non usava il soprannome. Non so come si chiamasse il padre, ma ho in mente la canottiera bianca sformata dalla pancia prominente, i pantaloncini e il mocassino; in inverno una giacca di un completo sopra la canottiera, i pantaloni e i mocassini; i capelli bianchi sempre rasati; d’inverno un cappello con il paraorecchie; era una di quelle persone che descriveresti in bianco e nero, intramontabili, perennemente uguali. Associo anche lui ad un personaggio animato: Patata dei Simpson, ma da vecchio e in scala di grigio. L’immaginario di un ragazzo si nutre dell’immaginazione dei grandi. Aveva una vespa bianca, il suo unico mezzo, parcheggiata illegalmente sotto il porticato della scuola, ed era incredibile come riuscisse a guidarla carica di sacchetti appesi al manubrio quando tornava dal Conad. Era un’icona di altri tempi, l’esempio di come la normalità venga trasformata negli anni in una caricatura del quotidiano. Camminava impettito nonostante l’età e l’aspetto trasandato: l’ho sempre visto vecchio e povero anche se quella vespa diceva giovane e benestante. La camminata la ereditò Trap, come la casa, la pancia e l’abitudine di portare una giacca; aggiunse però all’andatura un’interpretazione personale: i piedi a papera, ma l’effetto non era comico come per Charlie Chaplin: quel lento passo divergente gli dava un’aria da gangster, come se volesse ostentare le sue scarpe di pelle o dimostrare di non voler evitare nessuno e di godersi i giudizi degli altri senza fretta. Ruggero divenne custode al museo e passeggiava per la città come fosse il Duca: impettito come il padre, un Panama in cima alla testa portata alta e la sigaretta che non lasciava mai sprovviste le labbra. Sembrava il grande attore che interpretò Percival Poswater nel film americano, tornato in Italia per riconciliarsi con il suo passato. Urbino è sempre stato il palcoscenico degli Urbinati, e lo sarà sempre. È una città ideale allestita per dare spettacolo e abitata da maschere e teatranti che fingono quando non recitano. Il passato di Ruggero nel nostro quartiere era stato memorabile e i vicini non riuscivano a scordarlo. Nonostante ci sforzassimo di recitare una sincera cordialità, un inquieto velo di disprezzo copriva il giudizio di tutti nei suoi confronti. Vecchie malattie infettavano il cortile: la dipendeza dal pregiudizio, un’epidemica apatia ed il cupo bigottismo tipico della timorata Italia cattolica.
La sceneggiatura si animò con l’ingresso di Marica, una donna che Trap era andato a pescare in riviera e che divenne la sua compagna e co-protagonista del dramma. S’ispirava a Marilyn: capelli ossigenati spumosi, rossetto, bigiotteria, tacchi alti e pelliccia; sculettava qualsiasi fosse la pendenza della strada. Non era una bella donna, ma era sfrontata come se lo fosse. Strillava a prescindere dalla distanza dell’interlocutore, un grido euforico, persino quando litigavano, e accadeva spesso. Sfuriate sceniche da far sembrare reali quelle dei film, tanto esagerate da dover essere per forza vere: lei che usciva di casa con il passo ampio, sebbene la gonna non lo permettesse, e lui che le urlava dietro dalla finestra «Torna qui!,troia!»: la macchina rossa se ne andava e dalla camera si sentiva confusione e rabbia oltre il muro. Poi tornava e facevano l’amore, forte, sfacciato, da non farci dormire fino alla fine. Quelle sere dalla loro finestra usciva una nebbia rosa: il sudore evaporava dai corpi accaldati e si mischiava al fumo appagante delle loro sigarette. Fumavamo fumanti, affacciati alla finestra della camera e gettavano al vento i mozziconi, come Trap faceva con le siringhe. Le cicche si ammucchiavano vicino al tombino trasportate lì dalla pioggia: Ruggero consumava le sigarette fino al filtro, Marica no, ma ci stampava l’impronta delle labbra colorate. Erano briciole che testimoniavano gli edilliaci attimi della loro esistenza, un modo per tenere traccia della vita, per farsi trovare o ripercorrerla. O semplicemente maleducazione.
Marica si trasferì da Trap. Nonostante la sua maschera fosse la più evidente, era probabilmente il personaggio che meno recitava. Dimostrò di avere una sensibilità autentica affezionandosi a Trap e ad Argo, il nostro cane, più di quanto non lo fossimo noi. Argo era un incrocio tra un dalmata ed un pastore maremmano, una nobile creatura agreste, il tipico cane da punkabbestia. Viveva prigioniero nel nostro giardino, un piccolo rettangolo di prato nascosto dalle case del centro storico. Le finestre del bagno e della cucina di Trap si affacciano sul regno di Argo. Arghino, lo chiamava Marica. Il loro rapporto era puramente verbale, si amavano come Romeo dal giardino e Giulietta dalla finestra, senza potersi mai accarezzare. Il desiderio di quel contatto spinse Argo a impennarsi sul recinto: il suo collare si incastrò su una delle cuspidi e rimase impiccato in quel gesto d’amore. A noi dissero che era scappato. Non ne fummo tanto scossi: Argo non aveva più l’attrazione di un cucciolo e ogni giorno rendeva più goffo il suo aspetto e meno gradito l’impegno che ci richiedeva. L’avere cura perde il suo fascino non appena ci si rende conto delle responsabilità che comporta, è per questo che molti amano i cactus: sono belli, non richiedono molte attenzioni e quando muoiono se ne trovano altri uguali. Marica pianse. Un pianto cafone ed esagerato di cui eravamo invidiosi: quel dolore avrebbe dovuto appartenerci invece ne eravamo aridi.
Come ignorammo quel lutto non considerammo nemmeno i sentimenti di Marica. Nella nostra fantasia addomesticata, la scomparsa del mezzo dalmata era associato esclusivamente all’amore ostentato di lei per le pellicce. Due più due, più Poswater, e le conclusioni erano tratte. Da quel giorno trasformammo Marica in Marcia, la putrida socia del nostro acerrimo nemico.
Per semplicità spesso si interpreta la realtà facendo collegamenti con episodi simili conosciuti, piuttosto di sforzarsi di comprendere il nuovo. Connotata come maligna l’icona di Poswatere di Crudelia, siamo portati a credere cattivi chiunque assomigli a quei personaggi, così come riconosciamo un pirata dalla benda sull’occhio. Molti ritengono che questo meccanismo associativo sia il principio fondamentale dell’esperienza, ma l’esperienza è solo un modo di mascherare il pregiudizio.
Il tossico passato di Trap fu per tutto il vicinato la palese causa della malattia che contrasse. Nei trasversi pettegolezzi che attraversavano i vicoli si percepiva una certa soddisfazione per quel tragico destino. Come se quel male fosse la giusta conseguenza o penitenza per gli “errori” fatti in gioventù, l’agire della divina provvidenza. Non c’era cattiveria in questi pensieri, ma ignoranza e frustrazione; la necessità di avere conferma della bontà dei propri principi, dei sacrifici fatti e delle privazioni subite. La malattia di Trap era l’inverarsi della loro educazione: drogarsi è sbagliato, se lo fai morirai giovane.
Finalmente la punizione giunse per il peccatore e ci fu occasione per tutti di dimostrare la propria carità e compassione. Dal sud arrivarono i parenti a prendersi cura del malato, come facevano per i cactus: il fratello di Trap, un fedele lettore de “La Torre di Guardia”, che non aveva mai vissuto nel quartiere da quando ho memoria, con moglie e due figli maschi: uno più grande di me di qualche anno e l’altro più piccolo. Marica fu allontanata senza molta considerazione, quasi fosse stata la causa di quella situazione, con le pellicce, la vanità ed i suoi altri vizi. L’eccentrica maschera di Marcia fece il suo effetto sull’opinione degli “infermieri” nonostante fosse la compagna di Trap, l’unica ad essergli stata vicino malgrado il suo passato, o forse proprio per il suo trascorso, e la sola ad aver capito che la redenzione non era sinonimo di guarigione.
Guardavo spesso con invidia il nipote di Ruggero girare per il cortile con la vespa del nonno. Non aveva l’età per guidarla e quella sfrontatezza descriveva l’indole trasgressiva presa dallo zio e dal nonno. Qualche tempo dopo guidò quella vespa fuori dal cortile, se la portò via come sua eredità. Trap morì a quarantacinque anni per delle complicazioni. Non credo sia stata una sorpresa, tutta la sua vita era stata complicata. Le tendine del carro funebre chiusero il sipario. Sembra sbagliato morire prima della vecchiaia, ma anche questo è un preconcetto.
La casa restò per qualche tempo una trap house; poi il fratello la risitemò per poterla affittare agli universitari come quasi tutte le case del centro. I vicini si lamentano della musica fino a tarda notte, delle feste, della sporcizia, ma gli studenti che vivono lì se ne fregano di quello che pensa la gente, proprio come faceva Ruggero: credo ne sarebbe contento.
Hanno chiamato la bambina, il prossimo dovrei essere io. Dalla finestra entra una corrente fresca. La nostra campagna notturna con le rade luci nel buio sembra specchiare il cielo. Tutti quei minuscoli buchi dai quali filtra una luce superiore: mozziconi lasciati lì per essere seguiti, o per maleducazione.
⏀